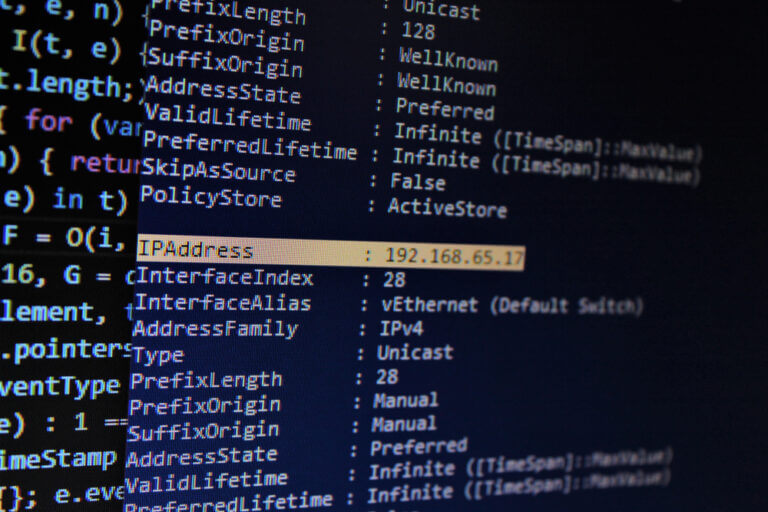Nuova pietra miliare sui dati personali e dati anonimi, che non sono affatto la stessa cosa. A stabilirne i confini è ancora una volta l’Autorità garante francese per la protezione dei dati (CNIL) la quale, nell’ammonire il motore di ricerca francese QWANT su come lo stesso tratta (ancora) i dati personali, chiarisce bene grazie anche ad approfondite analisi tecniche, le differenze tra dati personali pseudonimizzati e dati anonimi.
gdpr
Dati personali pseudonimizzati e anonimi, la CNIL chiarisce bene la differenza
L’Autorità privacy francese, intervenendo sul caso del motore di ricerca Qwant, ha confermato la sua interpretazione molto ampia della nozione di dati personali rispetto a quella di dati anonimi. Nel testo i dettagli sul caso, fugando le oscillazioni tra individuazione e identificazione
Avvocato, Privacy Specialist & Legal Compliance e nuove tecnologie – Giornalista

Continua a leggere questo articolo
Who's Who
Argomenti
Canali
Con o Senza – Galaxy AI per il business